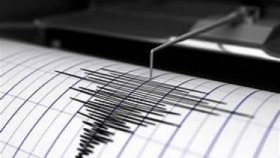Il Papa a Napoli: "Il Mediterraneo è il mare del meticciato, aperto all'incontro"
Papa Francesco è a Napoli per partecipare ad un convegno di studi alla Facoltà teologica dell'Italia meridionale. Ad accoglierlo il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, il presidente della giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca, oltre l'arcivescovo di Napoli Crescenzio Sepe. Il Papa è giunto in elicottero al parco Virgiliano e ha raggiunto in auto via Petrarca, destinazione la facoltà teologica dell'Italia meridionale (sezione San Luigi) dove si svolge il convegno di studi Veritatis Gaudium. Presente all'evento anche il presidente della Conferenza Episcopale Italiana, card. Gualtiero Bassetti, ha inviato una lettera al convegno che ospita l'intervento di Papa Francesco anche il Patriarca ecumenico di Costantinopoli Bartolomeo I.
«Signori Cardinali, Cari fratelli Vescovi e Sacerdoti, Cari professori e cari studenti - così ha esordito nel suo intervento Papa Francesco -. Sono lieto di incontrarmi oggi con voi e di prendere parte a questo Convegno. Ricambio di cuore il saluto del caro fratello il Patriarca Bartolomeo, che ha voluto contribuire alla riflessione con un suo personale messaggio. Il Mediterraneo è da sempre luogo di transiti, di scambi, e talvolta anche di conflitti. Questo luogo oggi ci pone una serie di questioni, spesso drammatiche. Esse si possono tradurre in alcune domande che ci siamo posti nell’incontro interreligioso di Abu Dhabi: come custodirci a vicenda nell’unica famiglia umana? Come alimentare una convivenza tollerante e pacifica che si traduca in fraternità autentica? Come far prevalere nelle nostre comunità l’accoglienza dell’altro e di chi è diverso da noi perché appartiene a una tradizione religiosa e culturale diversa dalla nostra? Come le religioni possono essere vie di fratellanza anziché muri di separazione? Queste e altre questioni chiedono di essere interpretate a più livelli, e domandano un impegno generoso di ascolto, di studio e di confronto per promuovere processi di liberazione, di pace, di fratellanza e di giustizia (...)».
«Il modo di procedere dialogico è la via per giungere là dove si formano i paradigmi, i modi di sentire, i simboli, le rappresentazioni delle persone e dei popoli. Giungere là ― come “etnografi spirituali” dell’anima dei popoli ― per poter dialogare in profondità e, se possibile, contribuire al loro sviluppo con l’annuncio del Vangelo del Regno di Dio, il cui frutto è la maturazione di una fraternità sempre più dilatata ed inclusiva. Dialogo e annuncio del Vangelo che possono avvenire nei modi tratteggiati da Francesco d’Assisi nella Regola non bollata, proprio all’indomani del suo viaggio nell’oriente mediterraneo. Per Francesco c’è un primo modo in cui, semplicemente, si vive come cristiani: «Un modo è che non facciano liti o dispute, ma siano soggetti ad ogni creatura umana per amore di Dio e confessino di essere cristiani» (XVI: FF 43). Vi è poi un secondo modo in cui, sempre docili ai segni e all’azione del Signore Risorto e al suo Spirito di pace, si annuncia la fede cristiana come manifestazione in Gesù dell’amore di Dio per tutti gli uomini. Questa docilità allo Spirito implica uno stile di vita e di annuncio senza spirito di conquista, senza volontà di proselitismo e senza un intento aggressivo di confutazione. Una modalità che entra in dialogo “dal di dentro” con gli uomini, con le loro culture, le loro storie, le loro differenti tradizioni religiose; una modalità che, coerentemente con il Vangelo, comprende anche la testimonianza fino al sacrificio della vita, come dimostrano i luminosi esempi di Charles de Foucauld, dei monaci di Tibhirine, del vescovo di Oran Pierre Claverie e di tanti fratelli e sorelle che, con la grazia di Cristo, sono stati fedeli con mitezza e umiltà e sono morti con il nome di Gesù sulle labbra e la misericordia nel cuore. E qui penso alla nonviolenza come orizzonte e sapere sul mondo, alla quale la teologia deve guardare come proprio elemento costitutivo. Ci aiutano qui gli scritti e le prassi di Martin Luther King e Lanza del Vasto e di altri “artigiani” di pace. Ci aiuta e incoraggia la memoria del Beato Giustino Russolillo, che fu studente di questa Facoltà, e di Don Peppino Diana, il giovane parroco ucciso dalla camorra, che pure studiò qui».
«“Dialogo” non è una formula magica, ma certamente la teologia viene aiutata nel suo rinnovarsi quando lo assume seriamente, quando esso è incoraggiato e favorito tra docenti e studenti, come pure con le altre forme del sapere e con le altre religioni, soprattutto l’Ebraismo e l’Islam. Gli studenti di teologia dovrebbero essere educati al dialogo con l’Ebraismo e con l’Islam per comprendere le radici comuni e le differenze delle nostre identità religiose, e contribuire così più efficacemente all’edificazione di una società che apprezza la diversità e favorisce il rispetto, la fratellanza e la convivenza pacifica. Con i musulmani siamo chiamati a dialogare per costruire il futuro delle nostre società e delle nostre città; siamo chiamati a considerarli partner per costruire una convivenza pacifica, anche quando si verificano episodi sconvolgenti ad opera di gruppi fanatici nemici del dialogo, come la tragedia della scorsa Pasqua nello Sri Lanka. Formare gli studenti al dialogo con gli ebrei implica educarli alla conoscenza della loro cultura, del loro modo di pensare, della loro lingua, per comprendere e vivere meglio la nostra relazione sul piano religioso. Nelle facoltà teologiche e nelle università ecclesiastiche sono da incoraggiare i corsi di lingua e cultura araba ed ebraica, e la conoscenza reciproca tra studenti cristiani, ebrei e musulmani (...)». «Il dialogo come ermeneutica teologica presuppone e comporta l’ascolto consapevole. Ciò significa anche ascoltare la storia e il vissuto dei popoli che si affacciano sullo spazio mediterraneo per poterne decifrare le vicende che collegano il passato all’oggi e per poterne cogliere le ferite insieme con le potenzialità. Si tratta in particolare di cogliere il modo in cui le comunità cristiane e singole esistenze profetiche hanno saputo ― anche recentemente ― incarnare la fede cristiana in contesti talora di conflitto, di minoranza e di convivenza plurale con altre tradizioni religiose. Tale ascolto dev’essere profondamente interno alle culture e ai popoli anche per un altro motivo. Il Mediterraneo è proprio il mare del meticciato, un mare geograficamente chiuso rispetto agli oceani, ma culturalmente sempre aperto all’incontro, al dialogo e alla reciproca inculturazione. Nondimeno vi è bisogno di narrazioni rinnovate e condivise che ― a partire dall’ascolto delle radici e del presente ― parlino al cuore delle persone, narrazioni in cui sia possibile riconoscersi in maniera costruttiva, pacifica e generatrice di speranza. La realtà multiculturale e pluri-religiosa del nuovo Mediterraneo si forma con tali narrazioni, nel dialogo che nasce dall’ascolto delle persone e dei testi delle grandi religioni monoteiste, e soprattutto nell’ascolto dei giovani. Penso agli studenti delle nostre facoltà di teologia, a quelli delle università “laiche” o di altre ispirazioni religiose. «Quando la Chiesa ― e, possiamo aggiungere, la teologia ― abbandona gli schemi rigidi e si apre ad un ascolto disponibile e attento dei giovani, questa empatia la arricchisce, perché “consente ai giovani di donare alla comunità il proprio apporto, aiutandola a cogliere sensibilità nuove e a porsi domande inedite”» (Esort. ap. postsin. Christus vivit, 65)».